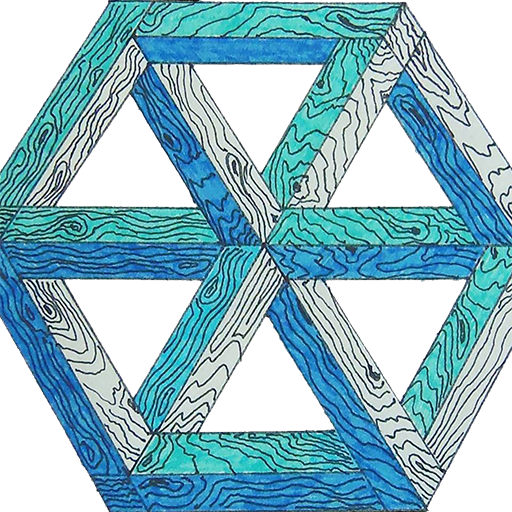Dipendenza da Videogame e realtà virtuale: da Navigatori a prede della rete
Il destino che è nel nostro Nome
C’è chi afferma che nel nostro nome sia scritto il nostro destino e mi sono ritrovato in più di una occasione a verificare che la questione è tutt’altro che “peregrina”. Così nell’esplorare la provenienza di un nome di un paziente, che sia essa legata al nonno o alla nonna, che sia ripreso da un personaggio famoso con forzature italianizzanti o che sia evocativo per altri motivi, mi sono più volte arreso, non tanto al fatto che nel nome v’è scritto il destino di un individuo, quanto al fatto che l’individuo tenta straordinariamente di confermare quanto è comunemente e profeticamente attribuito a quel nome.
In tal senso una Gioia mostrerà compulsivamente gioia, un Libero si dichiarerà tale e chi ha il nome del proprio nonno/a gli o le somiglierà. Una somiglianza di personalità, di modi, di gusti ecc. che verrà altrettanto rinforzata dai familiari, che vivranno alla perenne ricerca di conferme in questa direzione, “snobbando” tutti i fattori che disconfermano.
Un nome può però diventare una “prigione”, questo nella misura in cui l’identità autentica di un individuo venga oscurata da quella pubblicamente accettata. Così ci sono dei bambini che giocano con un nome che si danno da soli, spesso per una tendenza all’autoidealizzazione (“io mi chiamo zorro”), più di rado nel tentativo di affrancarsi da un nome reale che è dissonante, ad esempio”Salvo” senza sentirsi tale.
Il significato di darsi un Nickname
Oggi esiste un battesimo virtuale che va sotto la dicitura di nickname. Tale battesimo ci è consentito dai Videogame e realtà virtuale in genere. Facebook, MSN e tutte le chatroom, ne sono il crogiuolo mentre i MUD, ossia quei giochi in rete dove oltre al nome si costruisce un intero personaggio e un’intera vita, ne sono l’esasperazione. Se ci chiediamo per quale motivo una persona si dedica ad una vita virtuale piuttosto che a quella reale, possiamo risponderci semplicemente dicendo che sta assecondando un bisogno, a volte patologico, di autobattezzarsi con un nome il cui destino ci piace di più ovvero ci appartiene di più.
A costo di cadere nel già noto, non posso mancare di dire che la rete è un luogo protetto in cui sperimentare modalità relazionali, in cui esprimere gusti o opinioni altrimenti indesiderate, oppure semplicemente un gioco per sfuggire a una vita reale poco piacevole. La questione è annosa perché tra chi condanna i videogames, perché inducono alla violenza, e chi li esalta perché riducono la violenza, esiste un modo intermedio e maturo di considerare le nuove tecnologie. Giungere fino a progettare e mettere in commercio, notizia vera questa, un videogioco di simulazione di stupri (con tanto di scelta della ragazza) nell’ottica secondo cui una pulsione virtualmente agita, la violenza carnale nella fattispecie, ridurrebbe la probabilità che venga agita nel reale, è proprio il risultato dell’esaltazione dell’empirismo. Non è un caso che questo videogioco, fortunatamente per noi ritirato dal commercio, sia stato proposto in Giappone, paese in cui esiste la cosiddetta sindrome Hikikomori, di bambini ritirati socialmente al punto di vivere chiusi nelle loro stanze stando sempre e solo sul Pc; un paese che ammette culturalmente tali sofferenze dovrebbe regolamentare meglio l’impiego di nuove tecnologie.
Il problema si pone proprio a fronte delle tante ricerche, non sempre di buona e rigorosa fattura, che ci informano di psicosi da videogame o da internet, con i media a far da coro con “gioca al videogioco della guerra e poi spara al cuginetto”, come titoli a stuprare le nostre menti. Il popolo, illuso di sovranità, si sottomette e addita la tecnologia come diabolico produttore del malessere contemporaneo, popolo dimentico del libero arbitrio che resta dono anonimo. Ma è proprio tra queste ricerche che trovai più di un contributo che, con tutta la correttezza procedurale, rilevava che chi gioca con i videogiochi violenti risulta poi meno violento. Questo non giustifica creare giochi con stupri anche perché oltre alle fonti è sempre bene verificare chi finanzia le ricerche. Se una azienda che produce videogame di guerra finanzia un Istituto di Ricerca per verificare la relazione tra i loro giochi e la violenza dei fruitori, non mi meraviglierei che i risultati della ricerca siano proprio quelli che favorirebbero le vendite piuttosto che il fallimento dell’azienda.
Per questi motivi Tra le tante ricerche preferisco citare quella che personalmente ho condotto presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nella quale ho indagato aspetti di personalità correlati ai soggetti che tendono di più ad usare videogame o realtà virtuali in genere (Chat, Mud, Social network ecc.). Raccontare tutti i risultati sarebbe tedioso, mentre mi sembra più interessante dire che, come avvenne per la fotografia, il cinema e la televisione, che vennero tacciate di diabolicità perché rubavano la realtà a se stessa, anche la realtà virtuale sta vivendo lo stesso destino mentre, a ben vedere, è come sempre banalmente uno strumento i cui rischi vanno sempre legati alle modalità di impiego.
In estrema sintesi dalla ricerca è emerso che per le nuove generazioni il virtuale è un mezzo per amplificare la relazionalità mentre per le vecchie generazioni è un mezzo per compensare le difficoltà relazionali e emotive. Si è inoltre rilevato che le donne in età avanzata tendono più a impiegare i giochi e il virtuale in genere in modo disfunzionale e difensivo. I risultati nel complesso suggeriscono che un nuovo mezzo di comunicazione viene utilizzato, in seno a una cultura, in modo disfunzionale inizialmente per poi trovare una sua collocazione e una sua normatività funzionale.
Eppure non possiamo non tornare all’idea del battesimo virtuale, al nickname e alla tendenza a reinventarsi ex novo nei social network. Non possiamo non sottolineare che, per alcune fasce della popolazione, questo costituisca una inesorabile divaricazione tra reale e ideale, tra ciò che sono e ciò che vorrei essere, o vorrebbero che io sia. Sottolineando che la distanza tra l’identità reale e quella ideale costituisce un indice di salute, nel qual caso sia ridotta, ovvero di sofferenza mentale qualora sia notevole, non possiamo negare che il nostro “Io” nella rete perde di lucidità e tende a illudersi di essere altro da se stesso, proprio in quei casi in cui c’è sofferenza mentale. Sono proprio quei soggetti in difficoltà che cercano partner nelle chat e che, laddove decidono di incontrarsi, vivono la profonda delusione non dell’altro che non è come ce se lo aspettava, ma di se stessi, del crollo di questo personaggio che, effimero, muore nel contatto con la realtà. La nostra personalità idealizzata viene meno fuori dalla rete e questo è traumatico in coloro che vivono una sofferenza mentale.
In tal senso non possiamo non fare un parallelismo con la tossicodipendenza da intendersi, qui, come l’incapacità di presentarsi, a se stessi e agli altri, per quello che si è, motivo per cui si arriva all’uso di eroina per accettarsi, di cocaina per farsi accettare. Un Sé ideale che è proprio quello nascente in rete e che può affascinare, come per un narciso postlitteram a specchiarsi nel mare della virtualità.
Preme però evidenziare che non è l’arma che spara ma chi preme il grilletto. Lì, sull’uomo dobbiamo concentrare la nostra attenzione, per aiutarlo se necessario, e non sullo strumento che non soffre e fa quello per cui è stato creato.
Il videogame è un gioco in video ma sempre un gioco e il gioco, storicamente, è simbolo di lotta contro la morte, contro le forze ostili; è un universo a sé in cui trovare il proprio posto; il gioco è ciò che preannuncia la sacralità delle feste; è senso di appartenenza che prevede la sospensione delle pene capitali; è un ponte con il mondo della fantasia; è una tregua. Delittuosa sarebbe l’idea di eliminarlo, diabolico rendere eterna la tregua.